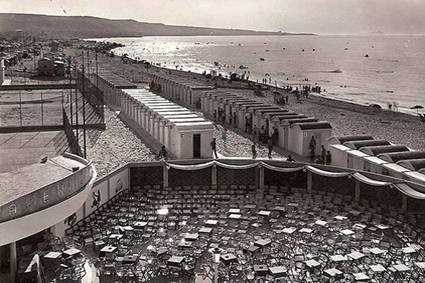Nonna Manghini – Testo di Egle Farris

Oggi la mia amata metà ha preparato le mezze maniche al pomodoro …..
 E il ricordo è tornato vivissimo e presente dopo più di mezzo secolo.
E il ricordo è tornato vivissimo e presente dopo più di mezzo secolo.
Nonna Manghini lavorava con una mano e mezza. L’altra mezza che le restava era sempre impegnata in “unu pittigu ‘e tabaccu “.
Perchè nonna era una delle ultime fra le donne del suo tempo che tabaccava. Rammento le sue due tabacchiere con il ” Sun di Spagna” e quel famoso rumore, tipo “clic clac”. Una tabacchiera che ricordo, forse, di corno con un tappo di consunto sughero e che appariva e spariva con gesti di maestria e magia da una tasca di quella gonna quasi lunga con la larga arricciatura, di colore sempre scuro a minuscoli fiorellini bianchi.
Nonna Manghini non possedeva grandi cose,ma teneva un bel comò, di quelli una chiave e quattro cassetti. Nella sua stanza era a destra, entrando, ed il primo cassetto era la grotta di Alì Babà per noi nipoti. Intanto le ostie. Perchè al tempo i farmaci, quasi sempre in polvere, venivano avvolti in un’ostia a formare i famosi, come diceva lei, “cascè” . Ma a noi piacevano solo le ostie , per l’appunto e le rubavamo in gran quantità, nascondendoci da qualche parte per sgranocchiarle. E quando se ne accorgeva ,noi eravamo belli che spariti ……
E poi quel barattolo di vetro pieno di polverina marrone, che altro non era che le spore di un fungo delle querce, la vescia, che era la panacea delle sbucciature delle ginocchia. Ci veniva elargita come polvere magica che faceva scomparire tutte le “bue” in un lampo di tempo, ma in effetti non aveva altra funzione che asciugare un pò di sangue. Meno male che la natura che protegge i bambini aveva disposto per noi miliardi di anticorpi ,se no quella polverina ci avrebbe spedito all’altro mondo per fare, come si diceva allora, la coroncina di angeli alla Madonna …….
E le mezze maniche ? Che c’entrano, vi state chiedendo …
Calma, ci arrivo …………
Le narici penso le avesse paralizzate, tipo gli odierni cocainomani , non doveva più sentire odori o profumi, olezzava sempre e solo di tabacco. E fu così che una volta, non avevo più di otto-nove anni, mia madre partì e lei, nonna, venne un giorno ad aiutare il figlio, mio padre, e preparare il pranzo .
E facemmo tutti e tre , babbo, Laerte ed io una rigorosissima giornata di dieta. Tutto sapeva di tabacco, ma il peggio furono le mezze maniche con “sa bagna “, che non era rossa come i pomodori di allora, ma aveva un bel color castagna che ci fece rabbrividire . E rimasero tutte tutte lì quelle mezze maniche , desolatamente abbandonate col loro sugo marroncino nel piatto, con la scusa che non avevamo fame ……
Una signora col rossetto Egle Farris




 Venivano al mio paese quando cominciavano i primi freddi. Un mulo macilento e affamato che implorava una sosta, e un carretto, che una volta doveva essere stato dipinto di giallo, pieno di sacchi di castagne. Lui, lunga barba, piccolo e secco con pantaloni rattoppati con decine di ritagli di stoffe diverse, che probabilmente ed inizialmente dovevano essere stati di fustagno, lei con un vecchissimo costume dalla caratteristica cuffietta, forse di Desulo, ancora più secca di lui. Andavano di paese in paese , vendendo quelle castagne raccolte con fatica ,mangiando poco e dormendo meno, perché le tettoie e le stalle dove si accampavano la notte dovevano essere gelide e respingenti . Oltre che vendere castagne, riparavano ombrelli e, piatti rotti , smerciavano umili oggetti di legno, mestoli, colini. Lui aveva un sacco con fili di ferro, ritagli di stoffe, aghi, ombrelli vecchissimi da cui ricuperare pezzi di ricambio. Testardo, rattoppava. cambiava stecche ossidate, manici mutilati o amputati del tutto in ombrelli neri o verdi, quelli enormi allora usati dai contadini. E ai poveracci che gli davano lavoro riparava anche piatti, zuppiere, vassoi di terracotta. Univa i vari cocci, dopo aver fatto due buchetti col ” girabacchino “, con un mastice bianchiccio e una graffa che presto sarebbe arrugginita, rendendo quelle stoviglie ancora più brutte e deturpate.
Venivano al mio paese quando cominciavano i primi freddi. Un mulo macilento e affamato che implorava una sosta, e un carretto, che una volta doveva essere stato dipinto di giallo, pieno di sacchi di castagne. Lui, lunga barba, piccolo e secco con pantaloni rattoppati con decine di ritagli di stoffe diverse, che probabilmente ed inizialmente dovevano essere stati di fustagno, lei con un vecchissimo costume dalla caratteristica cuffietta, forse di Desulo, ancora più secca di lui. Andavano di paese in paese , vendendo quelle castagne raccolte con fatica ,mangiando poco e dormendo meno, perché le tettoie e le stalle dove si accampavano la notte dovevano essere gelide e respingenti . Oltre che vendere castagne, riparavano ombrelli e, piatti rotti , smerciavano umili oggetti di legno, mestoli, colini. Lui aveva un sacco con fili di ferro, ritagli di stoffe, aghi, ombrelli vecchissimi da cui ricuperare pezzi di ricambio. Testardo, rattoppava. cambiava stecche ossidate, manici mutilati o amputati del tutto in ombrelli neri o verdi, quelli enormi allora usati dai contadini. E ai poveracci che gli davano lavoro riparava anche piatti, zuppiere, vassoi di terracotta. Univa i vari cocci, dopo aver fatto due buchetti col ” girabacchino “, con un mastice bianchiccio e una graffa che presto sarebbe arrugginita, rendendo quelle stoviglie ancora più brutte e deturpate.





 Secondo i giorni il signor Mario o Tore, storici abusivi con una seicento multipla, focomelica senza muso, venivano
Secondo i giorni il signor Mario o Tore, storici abusivi con una seicento multipla, focomelica senza muso, venivano