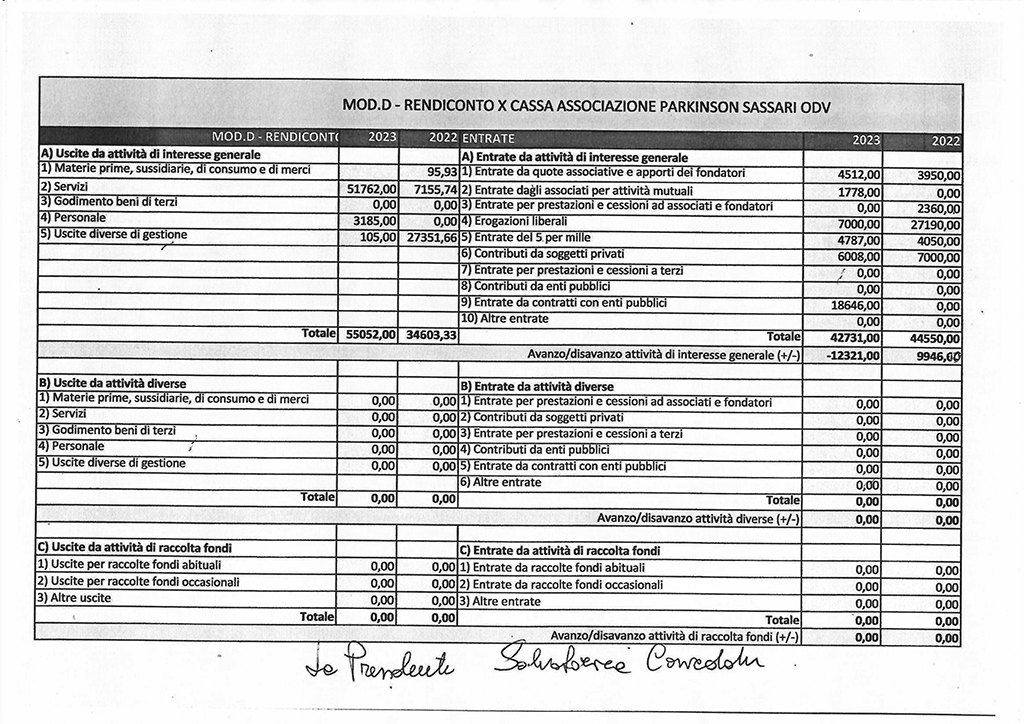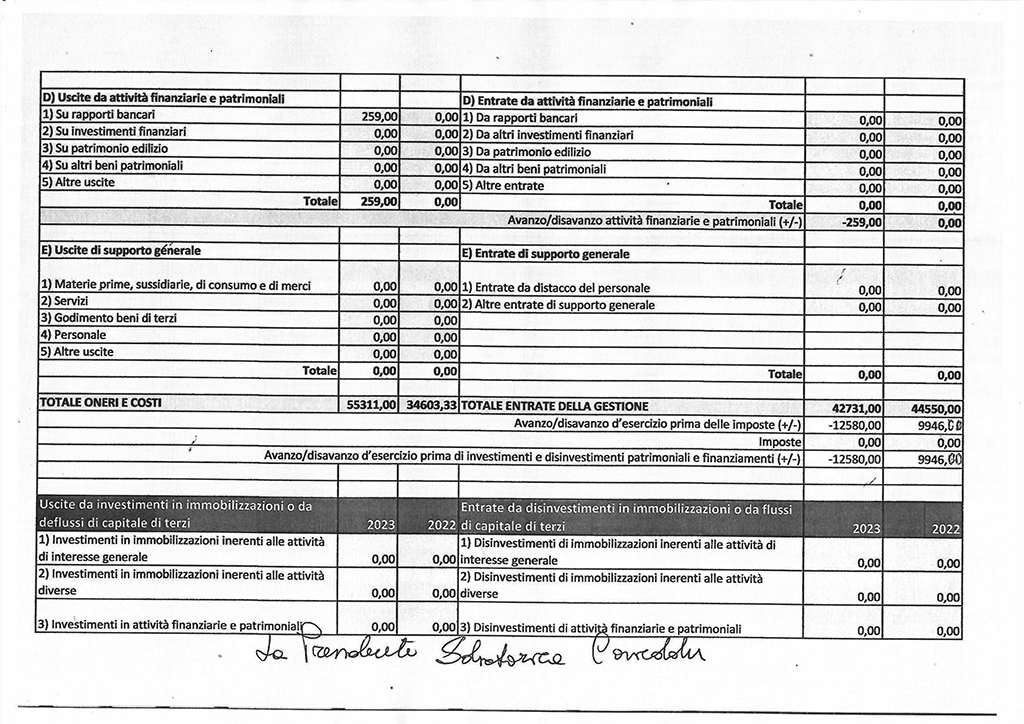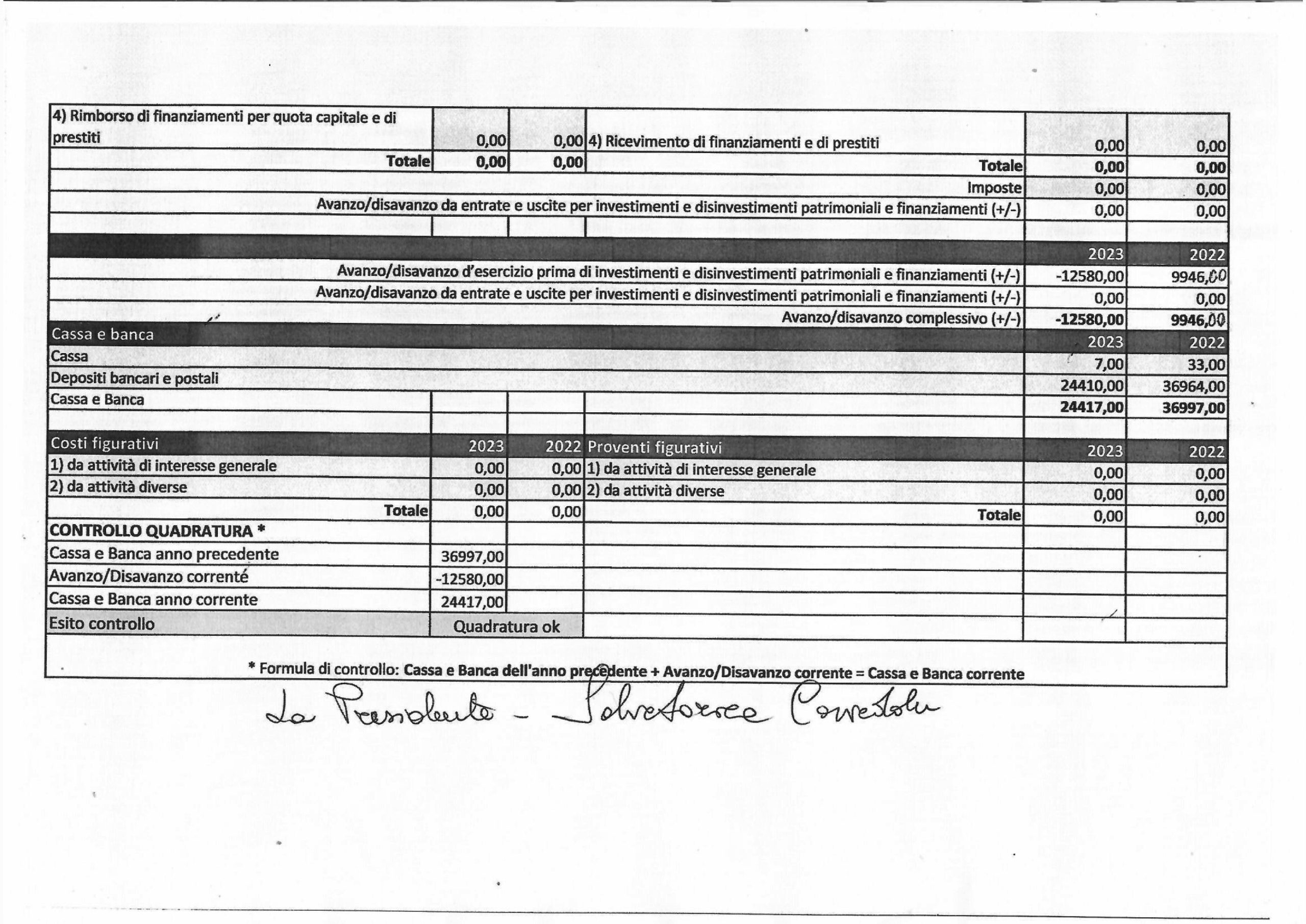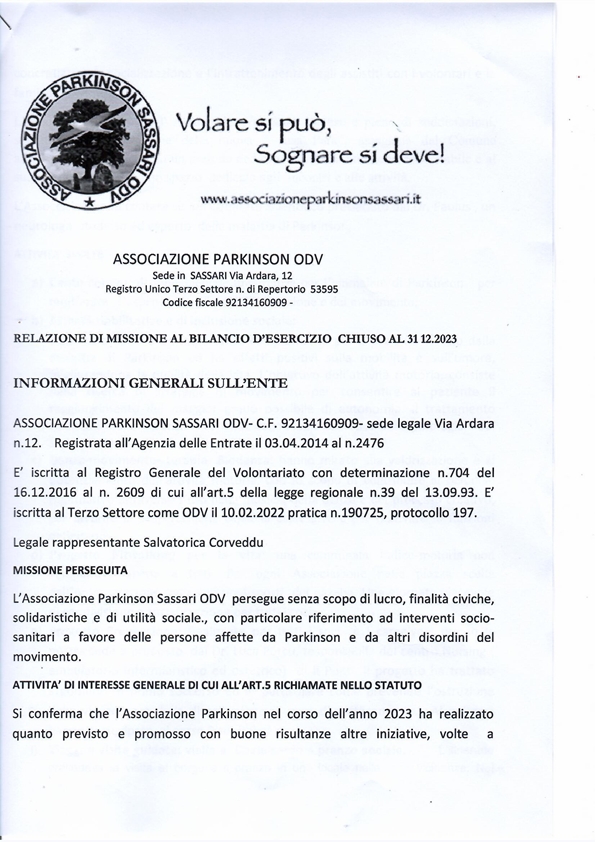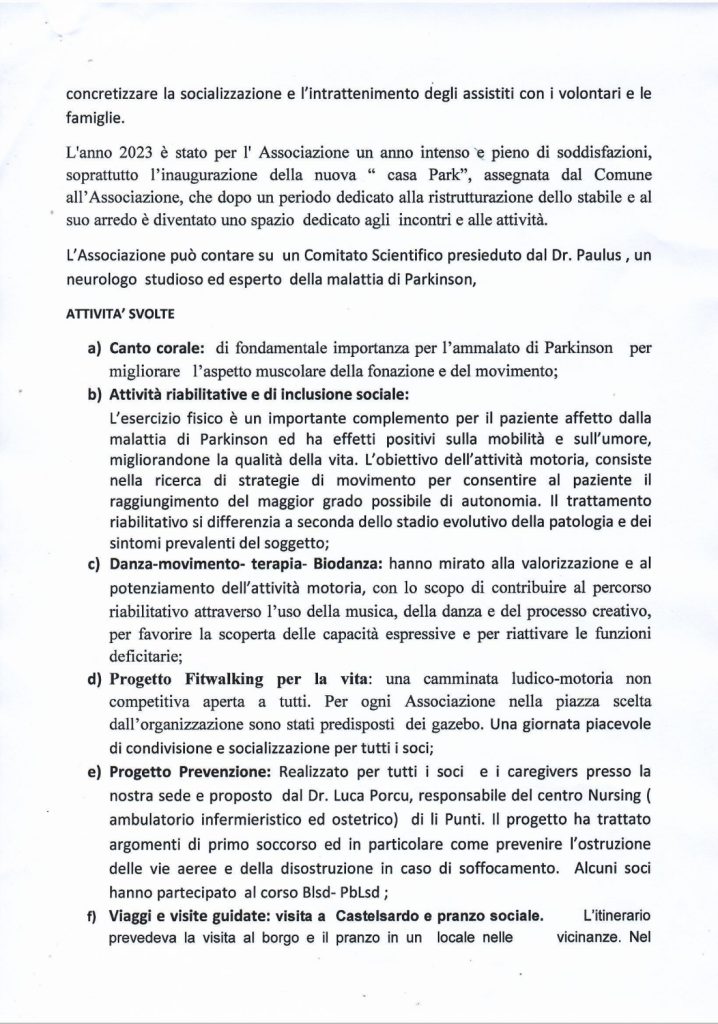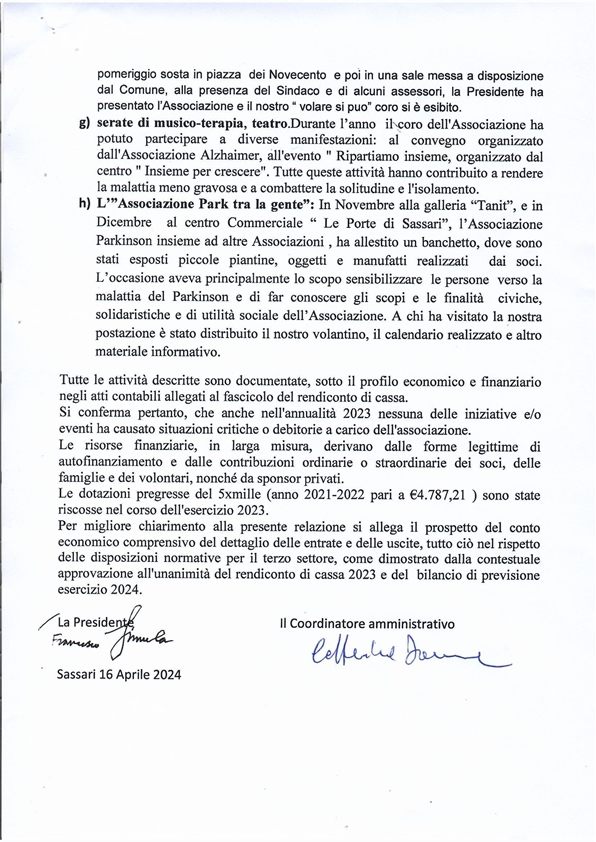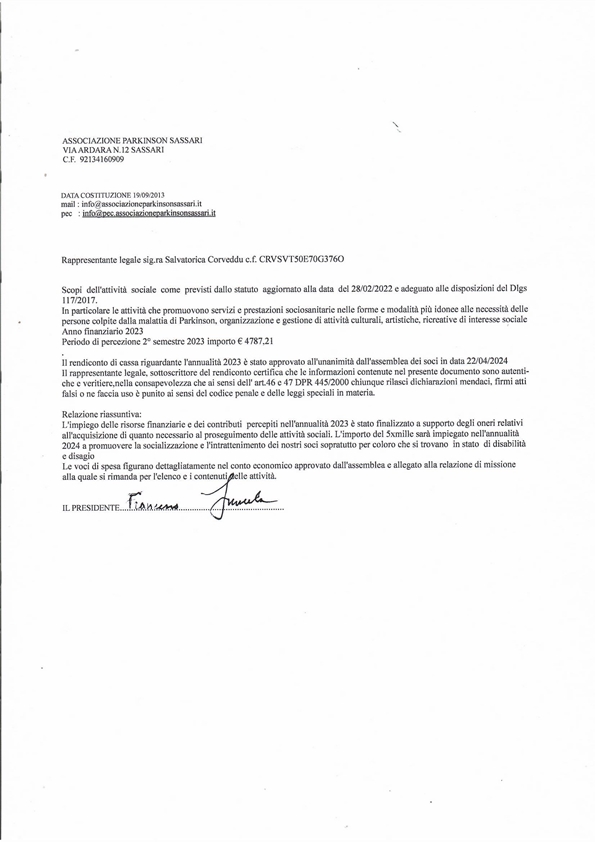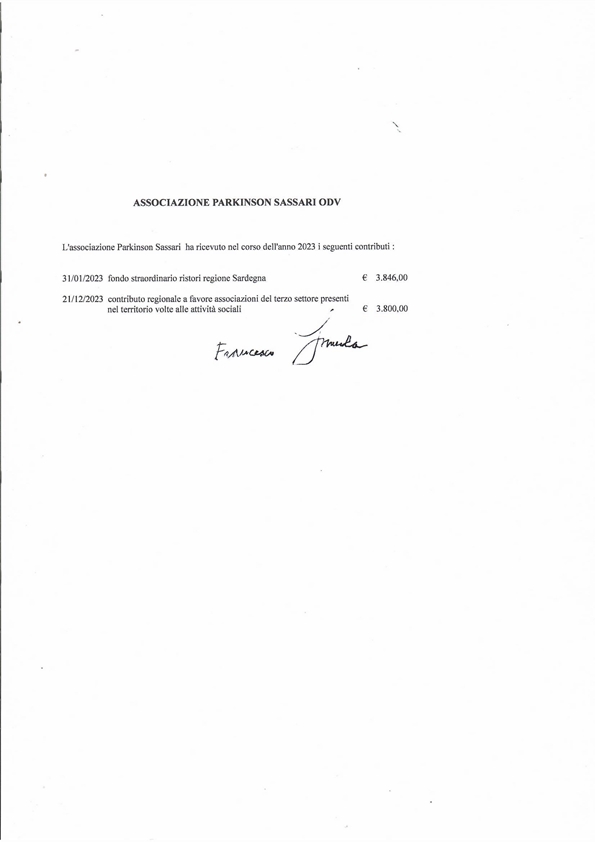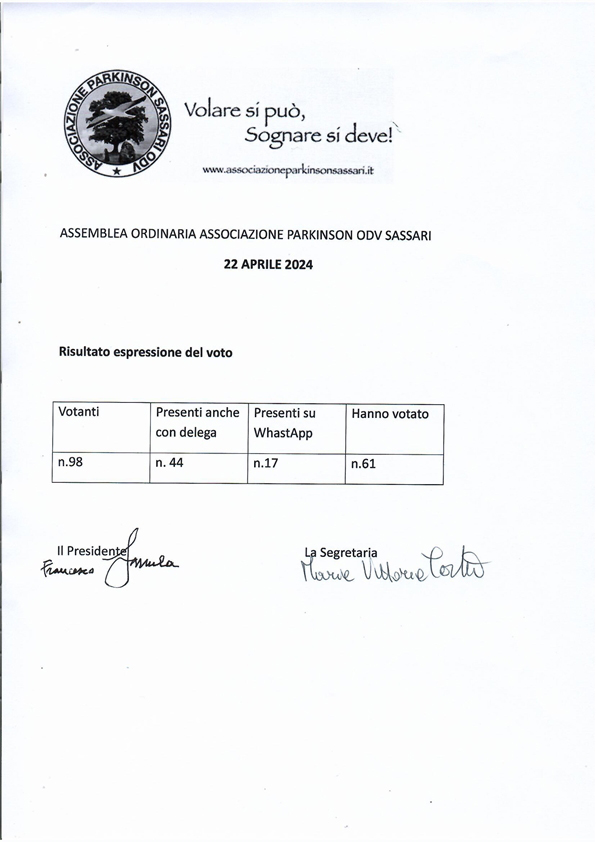Campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani
Che c’entra F. Kafka? testo di Romano Murineddu
Che c’entra F. Kafka?
Ho visto un bambino gattonare da solo. Avanzava, si fermava, si voltava a guardare il padre dietro di lui, e poi riprendeva senza paura. Così, diverse volte, fino ad allontanarsi tanto che molti erano in apprensione, ma non lui né il padre.
Non ho potuto resistere a questa immagine. Forse perché mi sono sentito come quel bambino oppure per la curiosità di vedere dove l’autore voleva andare a parare. Ho subito avvertito che la cosa poteva riguardarmi. In prima battuta magari come padre, perché anch’io ho un figlio che “gattona” e non è né sarà mai capace di affrontare la vita senza paura. Ma, posso essere stato io, e sarò, il padre rassicurante che gli dà la forza e la spinta per proseguire nella sua strada? Il mio deficit neurologico è compatibile con questa funzione che il destino mi ha assegnato, coinvolgendo tutto me stesso al massimo delle mie capacità?
L’autore dello scritto (Alessandro D’Avena, cura una rubrica del Corriere di lunedì) è un professore-scrittore-sceneggiatore particolarmente impegnato nell’analisi dei disagi adolescenziali e nell’esplorazione delle strade per aiutare a superarli. Normalmente non sono molto attratto da questo tipo di argomenti, perché adolescente non sono più da un bel pezzo e il mio spazio nel mondo è chiuso in un orizzonte sempre più ristretto e ingrigito da nubi minacciose, e perché sono tendenzialmente portato a cercare verità e ristoro in altri campi di interesse più concreto e pertinente. Quindi un lettore della rubrica per caso.
Lo scritto ha per titolo “kafkiano” e, facendo riferimento alla ricorrenza del centenario della morte di Franz Kafka, espone il contenuto di un libro intitolato “Conversazioni con Kafka” di Gustav Janouch. Costui, da adolescente, conobbe lo scrittore e lo ebbe come amico e mentore.
Il fatto sorprendente è che il contenuto di queste Conversazioni, citate nell’articolo, ha subito richiamato alla mente le recenti ammonizioni del nostro mentore e terapeuta che, in pubblico e in privato, non perde occasione per richiamarci al massimo impegno e alla massima saggezza nell’uso dei mezzi di cura per il nostro male: che sono di tipo farmacologico innanzitutto ma anche, e in modo rilevante, di motivazioni che toccano la sfera emotiva e il sentimento.
La lettura di Kafka ha attratto l’attenzione di adolescenti, per lo meno così era ai miei tempi, per le tinte forti, surreali e fuori dell’ordinario dei suoi scritti. La sua visione della vita votata alla rassegnazione e al cupo pessimismo sono sempre stati cibo quotidiano di cui si nutre voracemente la mente giovanile. Cibo però di certo poco appetibile ed entusiasmante per le persone sofferenti di Parkinson le quali, in misura più o meno marcata, vivono nell’angoscia di un domani che può essere tragico e che comunque sarà greve di difficoltà. Eppure, sentite un po’:
Kafka lo spiega così a Janouch che aveva definito pieno d’amore un suo racconto: «“L’amore non è nel racconto, bensì nell’oggetto della narrazione, nella gioventù”, … “Sono i giovani a essere pieni di sole e di amore. La gioventù è felice, perché possiede la facoltà di vedere la bellezza. Quando si perde questa facoltà, comincia la vecchiaia, la decadenza, l’infelicità”. “La vecchiaia esclude dunque ogni possibilità di essere felici?”. “No. È la felicità che esclude la vecchiaia: chi mantiene la facoltà di vedere la bellezza non invecchia”
Dr K. Paulus docet…
Non so e forse non è dato sapere se Kafka abbia mai conosciuto la malattia di Parkinson, ma il suo acuto modo di mettere a nudo gli affanni dell’animo umano fa quasi pensare che stia parlando di noi: che i pensieri, che ci angustiano e addebitiamo al nostro stato di malati, non sono altro che le stesse angosce che sopravvengono quando si diventa vecchi.
La mia esperienza della malattia non è più vecchia di circa 4/5 anni e vale ben poco, e non sono certo in grado di suggerire a nessuno neppure un utile consiglio di valido comportamento. Quanti possono esserlo? Eppure una piccola esperienza – in realtà grande nella sua tragicità – l’ ho vissuta: la dolorosa perdita di un amico, ammalato di Parkinson, avvenuta nel giro di pochi anni. Non so se ciò è avvenuto per la particolare gravità con cui la malattia ha colpito o per la concomitanza di altre complicazioni: il ricordo che resterà per sempre impresso è lo sguardo spento e la postura inerte che facevano trasparire quello che già all’interno era sopravvenuto. L’isolamento, l’abbandono e la rinuncia alla vita.
L’immagine del bambino che gattona richiama riflessioni che tutti conosciamo bene. Quando mi sono aggregato e ho conosciuto i compagni di viaggio dell’Associazione mi ha subito colpito un aspetto. Cosa ci fanno tutte quelle persone che la frequentano senza averne titolo, nel senso che non hanno la fortuna di godere della malattia di Parkinson? Molti sono famigliari o accompagnatori, necessari per il sostegno fisico dei malati che ne hanno bisogno, ma molti sono solo persone, generalmente anziane, che hanno piacere e desiderio di stare insieme.
Il genitore che osserva e vigila sul bambino in pratica è quella rete invisibile che ci unisce tutti e ci impedisce di cadere o di perderci. Ci spinge a comunicare tra noi, rivolgendoci l’un l’altro col nome di battesimo, accompagnando il discorso col contatto fisico di un braccio o di una spalla per far sentire anche fisicamente la vicinanza e l’empatia che ci lega. Far sentire la propria voce è una manifestazione di vita, il presupposto per non “morire dentro”. Che non riguarda solo il Parkinson, ma l’umanità tutta.
Le Fraccette – testo di Franco Simula
 Le Freccette
Le Freccette
Finalmente sono arrivate le freccette. Dott.Paulus ce ne aveva parlato tanto tempo fa, quasi favoleggiandone, ma poi per lunghi periodi era calato quasi l’oblio, non se ne parlava più.
Aiuta l’equilibrio, stimola l’attenzione, contrasta le emozioni:ma allora perché non arrivano le freccette? Chi le blocca? E’ bastata una telefonata “clandestina” e le freccette sono comparse come per incanto presentate dall’intero Direttivo del DART CLUB 4 MORI.
Daniele Muroni, presidente, Gian Mario Coghene e Pietro Gaiglia dirigenti, accompagnati da una torma di bambini “freccettari” sono arrivati in gruppo, festanti, a presentare lo sport delle freccette agli incuriositi soci dell’Associazione Parkinson Sassari. Ed è stata un’autentica festa.
Dopo aver montato due bersagli, gli ospiti hanno dato qualche dimostrazione dei lanci spiegando nel contempo le regole del gioco.
Era arrivato, intanto, anche per i parkinsoniani, il momento di misurarsi con le freccette.
Dopo qualche momento di titubanza qualcuno si fa avanti a provare: l’esperimento sembra essere gradito, in men che non si dica davanti al bersaglio si forma una fila, poi si dichiarano sfide fra coppie e in poco tempo…”si accettano scommesse”! L’atmosfera appare gioiosamente surriscaldata.
Si accende il tifo. Il decano ultranovantenne azzecca una tripla di settore mentre una signora che ci ha preso gusto centra il Bull Rosso da 50 punti. C’è un’euforia dilagante. Insomma il gioco delle freccette è piaciuto e il DART CLUB 4 MORI ha centrato il suo obiettivo.
Franco Simula